fiction.wikisort.org - Personaggio
Empedocle (in greco antico: Ἐμπεδοκλῆς, Empedoklês; in latino: Empedŏcles; ... – ...; fl. V secolo a.C.) è stato un filosofo e politico siceliota, vissuto nel V secolo a.C. ad Akragas (oggi Agrigento)[1]. Aristotele lo indica come padre della retorica.

Appartenente all'età presocratica, la filosofia di Empedocle è conosciuta per la teoria cosmogonica dei quattro elementi classici, da lui chiamati "radici" (ριζώματα, rizòmata), accanto ai quali egli pose due ulteriori principi: Amore (Φιλότης), in grado di mescolarli, e Odio (Νεῖκος), responsabile della loro separazione.
Influenzato dai pitagorici, Empedocle si oppose alla pratica del sacrificio di animali e alla loro uccisione a scopo nutritivo. Sviluppò anche una dottrina distintiva della reincarnazione. È generalmente considerato l'ultimo filosofo greco ad aver messo per iscritto in versi le sue idee; tra i presocratici, le sue opere sono quelle che più di ogni altro autore sono sopravvissute. La morte di Empedocle, avvenuta in circostanze misteriose, forse per essersi gettato volontariamente nell'Etna[2], è stata mitizzata dagli antichi scrittori ed oggetto di numerose opere letterarie.
Biografia
L'anno della nascita
Stabilire con sufficiente precisione il periodo in cui è vissuto Empedocle è di importanza fondamentale per cogliere l'originalità di questo filosofo rispetto ai suoi predecessori, Parmenide e Anassagora[3].

- Secondo Platone[4] Socrate da giovane incontrò Parmenide che aveva circa sessantacinque anni. Poiché Socrate morì all'età di settanta o più anni nel 399 a.C., l'incontro tra Socrate e Parmenide dovrebbe aver avuto luogo prima del 450 a.C., e, siccome secondo il testo di Platone «Socrate era molto giovane»[5], Denis O'Brien ritiene che questi non poteva aver superato i vent'anni: quindi Parmenide dovrebbe essere nato intorno al 515 a.C..
- Trasillo di Mende, l'astrologo vicino all'imperatore Tiberio, nonché editore degli scritti di Democrito, indica la nascita di quest'ultimo filosofo cinquant'anni dopo quella di Parmenide, quindi nel 470/469 a.C.; Diogene Laerzio sostiene che Democrito fosse «giovane ai tempi in cui Anassagora era vecchio»: se la differenza di età era intorno ai trent'anni si può verosimilmente ritenere che Anassagora nacque ai primi del secolo così come testimoniato dall'erudito Apollodoro di Atene (II secolo a.C.) mentre Simplicio / Teofrasto sostiene che Empedocle fosse nato «qualche tempo» dopo Anassagora.
- Aristotele sostiene che Anassagora fosse hýsteros (ὕστερος) rispetto a Empedocle, ma tale termine può significare sia "successivo" che "inferiore" quindi molti esegeti hanno letto come se Anassagora fosse "successivo" a Empedocle; tuttavia lo Stagirita attribuendo ad ambedue i filosofi la nozione di "forza motrice" sostiene che fu scoperta per primo da Anassagora. O'Brien conclude quindi che ὕστερος vada letto come "inferiore" e non come "posteriore", ovvero: Anassagora più vecchio di Empedocle, secondo Aristotele, gli fu "inferiore".
|
«Approdiamo così a una cronologia i cui tratti essenziali sono ben attestati dai documenti antichi. Parmenide è di una quindicina di anni più anziano di Anassagora, nato tra il VI e il V secolo. Empedocle, di qualche anno soltanto più giovane di Anassagora, è dunque più vecchio di Democrito, nato una trentina di anni dopo Anassagora nel 470/469.» |
| (Denis O'Brien, Empedocle in Il sapere greco. Dizionario critico, vol. 2 (a cura di Jacques Brunschwig e E.R. Lloyd). Torino, Einaudi, 2007, pp. 81-82) |
Si sarebbero quindi succeduti per la nascita: Parmenide, Anassagora, Empedocle e Democrito.
Vita politica e appartenenza filosofica
Secondo il racconto di Diogene Laerzio, Empedocle nacque da una famiglia antica, nobile e ricca di Agrigento[6]. Come suo padre Metone, che ebbe un ruolo importante nell'allontanamento del tiranno Trasideo da Agrigento nel 470, egli partecipò alla vita politica della città negli anni fra il 446 e il 444 a.C., schierandosi dalla parte dei democratici e contribuendo al rovesciamento dell'oligarchia formatasi all'indomani della fine della tirannide, un governo chiamato dei "Mille". La tradizione gli attribuisce uno spirito caritativo nei confronti dei poveri[7] e severo verso gli aristocratici[8]. Si dice anche che abbia rifiutato il governo della città che gli era stato offerto[9].

Dai suoi nemici fu poi esiliato nel Peloponneso, dove forse conobbe Protagora ed Erodoto. Tra i suoi discepoli vi fu anche Gorgia.
|
«Successivamente Empedocle abolì anche l'assemblea dei Mille, costituita per la durata di tre anni, sì che non solo appartenne ai ricchi, ma anche a quelli che avevano sentimenti democratici. Anche Timeo nell'undicesimo e nel dodicesimo libro - spesso infatti fa menzione di lui - dice che Empedocle sembra aver avuto pensieri contrari al suo atteggiamento politico. E cita quel luogo dove appare vanitoso ed egoista. Dice infatti: 'Salve: io tra di voi dio immortale, non più mortale mi aggiro'. Etc. Nel tempo in cui dimorava in Olimpia, era ritenuto degno di maggiore attenzione, sì che di nessun altro nelle conversazioni si faceva una menzione pari a quella di Empedocle. In un tempo posteriore, quando Agrigento era in balìa delle contese civili, si opposero al suo ritorno i discendenti dei suoi nemici; onde si rifugiò nel Peloponneso ed ivi morì[10].» |
Sempre secondo il racconto di Diogene Laerzio, entrò nella scuola pitagorica divenendo allievo di Telauge, il figlio di Pitagora. Seguì la dieta vegetariana pitagorica e rifiutò i sacrifici cruenti: secondo la leggenda, dopo una vittoria olimpica alla corsa dei carri, per attenersi all'usanza secondo cui il vincitore doveva sacrificare un bue, ne fece fabbricare uno di mirra, incenso ed aromi, e lo distribuì secondo la tradizione[11].
Secondo altri, seguì gli insegnamenti di Brontino e di Epicarpo.
Aneddoti e leggende
La sua oratoria brillante[12], la sua conoscenza approfondita della natura, e la reputazione dei suoi poteri meravigliosi, tra cui la guarigione delle malattie, e la capacità di scongiurare le epidemie, hanno prodotto molti miti e storie che circondano il suo nome:
|
«Scoppiata una pestilenza fra gli abitanti di Selinunte per il fetore derivante dal vicino fiume, sì che essi stessi perivano e le donne soffrivano nel partorire, Empedocle pensò allora di portare in quel luogo a proprie spese (le acque di) altri due fiumi di quelli vicini: con questa mistione le acque divennero dolci. Così cessò la pestilenza e mentre i Selinuntini banchettavano presso il fiume, apparve Empedocle; essi balzarono, gli si prostrarono e lo pregarono come un dio[13]. Volle poi confermare quest'opinione di sé e si lanciò nel fuoco[14][15].» |
![Il vulcano Etna, dove Empedocle si sarebbe ucciso[16].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/EtnaAvi%C3%B3.JPG/240px-EtnaAvi%C3%B3.JPG)
Si diceva che fosse un mago, capace di controllare le tempeste; e lui stesso, nel suo famoso poema Le purificazioni, sembra avesse affermato di avere miracolosi poteri, compreso quello della distruzione del male, della guarigione dalla vecchiaia e del controllo di vento e pioggia.
I sicelioti lo veneravano come profeta e gli attribuivano numerosi miracoli.
Le numerose testimonianze che riguardano la sua biografia sono alquanto discordanti e non consentono di attribuire un'identità precisa alla sua figura. A conferma di ciò sono le numerose leggende sul suo conto. I suoi amici e discepoli raccontano ad esempio che alla morte, essendo amato dagli dèi, fu assunto in cielo; mentre Eraclide Pontico, Luciano di Samosata e Diogene Laerzio sostengono che si suicidò gettandosi nel cratere dell'Etna[17]. Il vulcano avrebbe eruttato, dopo qualche istante, uno dei suoi famosi sandali di bronzo[18][19]. In realtà non sappiamo neanche se sia morto in patria o forse nel Peloponneso[20].
Secondo Aristotele, Empedocle morì all'età di 60 anni (ca. 430 a.C.), mentre altri autori affermano che visse fino all'età di 109[21].
Nella Suida si trova questa descrizione del modo di vestire di Empedocle: «Una sorta di ornamento (sandali) che portava ai piedi, con una corona dorata sul capo, e bronzei calzari ai piedi e nastri delfici nelle mani. Così abbigliato andò di città in città desiderando di tenere salda la sua reputazione di apparire come un dio. Di notte lanciò se stesso dentro i crateri della fiammeggiante Etna, ma un suo sandalo fu ributtato fuori. Egli venne appellato col nome di Kolusamenas (trattenitore di venti) risparmiando la città di Akragas dalle forti raffiche a lei contrarie, innalzando intorno alla città pelli di asino»[22].
Una biografia di Empedocle scritta da Xanto di Lidia, suo contemporaneo, è andata perduta[23].
Pensiero e opere
A Empedocle la tradizione attribuisce numerose opere, fra cui anche alcuni trattati – sulla medicina, sulla politica e sulle guerre persiane – e tragedie. A noi sono giunti però solo frammenti dei due poemi: Sulle Origini o Sulla natura (Περὶ Φύσεως, Perì phýseōs, titolo per altro comune a molte opere filosofiche antiche)[24] e Purificazioni (Καθαρμοί, Katharmoí). Della prima, di carattere cosmologico e naturalistico, sono rimasti circa 400 frammenti di diseguale ampiezza sugli originali 2000 versi, mentre della seconda, di carattere teologico e mistico, abbiamo poco meno di un centinaio rispetto agli originali 3000. La lingua da lui usata è il dialetto ionico. È stata anche sollevata l'ipotesi[25]. priva di sufficiente fondamento, che questi due titoli si riferiscano a una singola opera[26].
Sulla natura
Il timore religioso[27] del filosofo di Agrigento appare fin dalle prime righe del Περί Φύσεως (Perí Physeos):
|
«o dèi, stornate dalla mia lingua follia di argomenti, |
| (Empedocle Poema fisico (Περί Φύσεως) Libro I Proemio (D-K 31 B 3), traduzione di Carlo Gallavotti. Milano, Mondadori/Fondazione Lorenzo Valla, 2013, p.9) |

La filosofia di Empedocle si presenta come un tentativo di combinazione sintetica delle precedenti dottrine ioniche, pitagoriche, eraclitee e parmenidee. Da quest'ultime accoglie la tesi dell'immutabilità e dell'eternità dell'Essere[28], ovvero che nulla nasce e nulla muore. Dalle altre accetta l'idea del divenire, del continuo e incessante mutamento delle cose. Empedocle – e come lui anche gli altri fisici pluralisti – cerca di risolvere questa contraddizione distinguendo la realtà che ci circonda, mutevole, dagli elementi primi, immutabili, che la compongono[29].
Empedocle chiama tali elementi "radici" (ριζώματα, rizòmata), non nate (ἀγένητα, agheneta)[30] ed eternamente uguali (ἠνεκὲς αἰὲν ὁμοῖα, enekes aien omoia)[31], e afferma che sono in tutto quattro, associando ognuno di essi a un particolare dio della mitologia greca, sulla base di concezioni orfiche e misteriche proprie dei riti iniziatici il cui luogo d'origine era la Sicilia orientale[32], non lontano dall'area (la Sicilia centro-meridionale) in cui fu attivo Empedocle. I quattro elementi (e i rispettivi dèi associati)[33][34] dunque sono:
L'unione di tali radici determina la nascita delle cose e la loro separazione, la morte. Si tratta perciò di apparenti nascite e apparenti morti, dal momento che l'Essere (le radici) non si crea e non si distrugge, ma è soltanto in continua trasformazione.
| (GRC)
«ἄλλο δέ τοι ἐρέω˙ φύσις οὐδενὸς ἔστιν ἁπάντων |
(IT)
«Ma un'altra cosa ti dirò: non vi è nascita |
| (Empedocle, D-K 31 B 8, traduzione di Gabriele Giannantoni in Presocratici vol.I, Milano, Laterza, 2009) | |
In questo modo «I primi principi si empiono così dell'essenza e del soffio vitale di poteri divini.»[37].
| Particolare dell'anfora del IV secolo a.C. (opera del cosiddetto "Pittore di Afrodite") conservata al Museo Archeologico Nazionale di Paestum |
|---|
 In Empedocle, Amore (Φιλότης) è indicato anche con il nome di Afrodite (Ἀφροδίτη)[38], o con il suo appellativo di Kýpris (Κύπρις)[39], indicando qui la «natura divina che tutto unisce e genera la vita»[40]. Tale accostamento tra Amore e Afrodite ispirò al poeta romano Lucrezio l'inno a Venere, collocato nel proemio del De rerum natura. In questa opera Venere non è la dea dell'amplesso, quanto piuttosto «l'onnipotente forza creatrice che pervade la natura e vi anima tutto l'essere», venendo poi, come nel caso di Empedocle, opposta a Marte, dio del conflitto[41]. |
|
«Empedocle occupa un posto a parte nella storia della filosofia presocratica. Se si prescinde da quella figura poco conosciuta e per qualche verso mitica che è Pitagora, egli appare in effetti il primo autore dell'Antichità a voler riunire contemporaneamente in un solo e medesimo sistema concezioni filosofiche e credenze religiose. […] nessun pensatore prima di lui aveva inserito all'interno di un quadro filosofico questa corrente di idee mistiche delle quali si troverà più tardi l'eco nelle iscrizioni funerarie dell'Italia meridionale e nei dialoghi di Platone: per Empedocle, infatti, come per gli anonimi autori delle iscrizioni funerarie, l'uomo, essendo di origine divina, non raggiungerà la vera felicità che dopo la morte, quando si riunirà alla compagnia degli dèi.» |
| (Denis O' Brien, Empedocle in Il sapere greco. Dizionario critico, vol. 2. Torino, Einaudi, 2007, p. 80) |
Accanto alle quattro "radici", e motore del loro divenire nei molteplici oggetti della realtà, si pongono due ulteriori principi: Φιλότης (Amore) e Νεῖκος (Odio, anche Discordia o Contesa); avente il primo la caratteristica di "legare", "congiungere", "avvincere" (σχεδύνην δὲ Φιλότητα «Amore che avvince»[42]), mentre il secondo possiede la qualità di "separare", "dividere" mediante la "contesa".
Così Amore nel suo stato di completezza è lo Sfero (Σφαῖρος), immobile (μονίη) uguale a se stesso e infinito (ἀλλ' ὅ γε πάντοθεν ἶσος〈ἑοῖ〉καὶ πάμπαν ἀπείρων[43]). Egli è Dio e le quattro "radici" le sue "membra", e quando Odio distrugge lo Sfero:
| (GRC)
«πάντα γὰρ ἑξείης πελεμίζετο γυῖα θεοῖο.» |
(IT)
«Tutte, l'una dopo l'altra, fremevano le membra del dio» |
| (Empedocle, D-K 31 B 31) | |
Infatti sotto l'azione dell'Odio (Νεῖκος), presente alla periferia dello Sfero, le quattro "radici" si separano dallo Sfero perfetto e beante, dando origine al cosmo e alle sue creature viventi: prima bisessuate e poi sotto l'azione determinante di Odio, si differenziano ulteriormente in maschi e femmine, e ancora in esseri mostruosi e infine in membra isolate; alla fine di questo ciclo, Amore (Φιλότης) riprende l'iniziativa e dalle membra isolate, nascono esseri mostruosi e a loro volta maschi e femmine, poi esseri bisessuati che finiscono per riunirsi, con le quattro "radici" che li compongono, nello Sfero[44][45].
Le Purificazioni
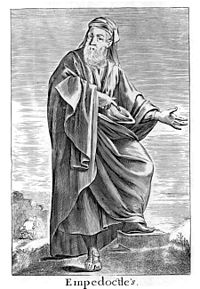
Nel secondo scritto a noi pervenuto, le Purificazioni (Καθαρμοι), Empedocle riprende la teoria orfica e pitagorica della metempsicosi, affermando l'esistenza di una legge di natura che fa scontare agli uomini le proprie colpe attraverso una serie continua di nascite e di morti, tramite cui l'anima, di origine divina, trasmigra da un essere vivente all'altro (animale o vegetale) per millenni.
In questo poema gli esseri viventi, parti costitutive dello Sfero di Amore divengono dèmoni (δαίμων) errando nel cosmo.
| (GRC)
«ἔστιν Ἀνάγκης χρῆμα, θεῶν ψήφισμα παλαιόν, |
(IT)
«È vaticinio della Necessità, antico decreto degli dèi |
| (Empedocle, D-K 31 B 115, traduzione di Gabriele Giannantoni in Presocratici vol.1, Milano, Mondadori, 2009, pp.410-411) | |
|
«L'Amore non interviene nella storia delle peregrinazioni del "demone" decaduto? Con ogni probabilità, è l'Amore stesso che ci parla in questo frammento. L'"io" dei due ultimi versi è l'autore del poema. Ma è anche, se andiamo più a fondo, l'Amore. I "demoni" esiliati "lontano dagli dèi" saranno allora dei frammenti espulsi dalla massa centrale dell'Amore e condannati a errare tra i corpi cosmici sotto l'influenza separatrice del suo nemico, la Discordia.» |
| (Denis O' Brien, Empedocle in La sapienza greca ... p. 90) |
|
«Quando le parti dell'Amore che sono i "demoni" si riuniscono nell'unità immobile della sfera, il mondo stesso diviene un essere vivente. Sotto l'influenza di Amore il mondo stesso si trasforma in dio» |
| (Denis O' Brien, Empedocle in La sapienza greca ... p. 90) |
Questa concezione conduce al rifiuto assoluto dei sacrifici, poiché in ogni essere vivente vi è un'anima umana, che sta compiendo il suo ciclo di reincarnazione. Se nel corso di questo ciclo l'anima si è comportata secondo giustizia, al termine potrà tornare nella sua condizione divina. Dal che, come Pitagora, anche a Empedocle ripugnano i sacrifici animali e l'alimentazione carnea:
| (GRC)
«διόπερ καὶ κτείνοντες αὐτὰ καὶ ταῖς σαρξὶν αὐτῶν τρεφόμενοι ἀδικήσομέν τε καὶ ἀσεβήσομεν ὡς συγγενεῖς ἀναιροῦντες. ἔνθεν καὶ παρήινουν οὗτοι οἱ φιλόσοφοι ἀπέχεσθαι τῶν ἐμψύχων καὶ ἀσεβεῖν ἔφασκον τοὺς ἀνθρώπους 'βωμὸν ἐρεύθοντας μακάρων θερμοῖσι φόνοισιν', καὶ Ἐ. πού φησιν 'οὐ … νόοιο'. οὐ παύσεσθε φόνοιο δυσηχέος; οὐκ ἐσορᾶτε ἀλλήλους δάπτοντες ἀκηδείηισι νόοιο» |
(IT)
«Onde, uccidendoli e nutrendoci delle loro carni, commetteremo ingiustizia ed empietà, come se uccidessimo dei consanguinei; di qui la loro esortazione ad astenersi dagli esseri animali e la loro affermazione che commettono ingiustizia quegli uomini «che arrossano l'altare con il caldo sangue dei beati», ed Empedocle dice in qualche luogo: Non cesserete dall'uccisione che ha un'eco funesta? Non vedete che vi divorate reciprocamente per la cecità della mente?» |
| (D-K 31 B 136, traduzione di Gabriele Giannantoni in Presocratici vol.1, Milano, Mondadori, 2009) | |
| (GRC)
«μορφὴν δ' ἀλλάξαντα πατὴρ φίλον υἱὸν ἀείρας |
(IT)
«Il padre sollevato l'amato figlio, che ha mutato aspetto, |
| (Empedocle D-K 31 B 137, traduzione di Gabriele Giannantoni in Presocratici vol.1, Milano, Mondadori, 2009) | |
Rispetto alla sua precedente opera vi sono delle contraddizioni che è stato difficile per i suoi esegeti conciliare. Ad esempio, ad una visione naturalistica del poema Sulla natura si contrappone la teoria della reincarnazione delle Purificazioni: nel primo scritto l'anima è anche detta mortale, mentre è definita immortale nel secondo. C'è chi ha spiegato tali incongruenze con la versatilità di Empedocle, scienziato e profeta al tempo stesso, medico e taumaturgo. C'è invece chi ha ipotizzato una paternità diversa delle due opere[46].
![Uno dei busti ritrovati nella Villa dei Papiri a Ercolano, identificato dapprima come Eraclito, solo più recentemente con Empedocle[47].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Busto_di_c.d._eraclito%2C_da_villa_papiri_ercolano%2C_copia_romana_da_orig._del_III_sec_ac.%2C_MANN_01.JPG/150px-Busto_di_c.d._eraclito%2C_da_villa_papiri_ercolano%2C_copia_romana_da_orig._del_III_sec_ac.%2C_MANN_01.JPG)
Riconoscimenti
Lo stile di Empedocle viene lodato dagli antichi:
| (LA)
«Dicantur ei quos physikoús Graeci nominant eidem poetae, quoniam Empedocles physicus egregium poema fecerit» |
(IT)
«Siano pure detti poeti anche coloro che i greci chiamano fisici, dal momento che il fisico Empedocle scrisse un poema egregio» |
| (Cicerone, De Oratore 1, 217) | |
|
«padre della retorica» |
| (Aristotele fr. 1, 9, 65) |
Lucrezio (De rerum natura 727 ss.) lo prende addirittura come modello.
Ernest Renan lo definisce «uomo di multiforme ingegno, mezzo Newton e mezzo Cagliostro»[48].
Nel 1861 gli viene intitolato il Regio Liceo Classico di Agrigento, dove studiarono, fra gli altri, Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. A Empedocle sono dedicate strade a : Palermo, Gela, Catania, Napoli, Milano.
A Empedocle è stato intitolato il vulcano sottomarino omonimo situato nel Canale di Sicilia, in riferimento alle circostanze presunte della sua morte.
Bibliografia
| Frammento del I secolo d.C., del poema Περί Φύσεως (Sulla natura o Sulle origini) | ||||
|---|---|---|---|---|

| ||||
Edizioni e traduzioni
- Carlo Gallavotti, Empedocle. Poema fisico e Lustrale, Milano, Mondadori, 1975.
- L'Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. Gr. Inv. 1665-1666), Introduzione, edizione del testo e commento a cura di Alain Martin e Olivier Primavesi, Berlino: Walter de Gruyter, 1999.
- Angelo Tonelli (a cura di), Empedocle di Agrigento. Frammenti e testimonianze. Origini, Purificazioni, con i frammenti del papiro di Strasburgo, traduzione delle testimonianze di Angelo Tonelli e Ilaria Ramelli, Milano: Bompiani, 2002.
- I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther Kranz, a cura di Giovanni Reale, Milano: Bompiani, 2006.
Studi
- Ettore Bignone, Empedocle. Studio critico, traduzione e commento delle Testimonianze e dei Frammenti, ristampa, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1963 [Torino: Bocca, 1916].
- Giorgio Colli, Empedocle, Milano, Adelphi, a cura di Federica Montevecchi, 2019, ISBN 9788845934377.
- Antonio Traglia, Studi sulla lingua di Empedocle, Bari, Adriatica, 1952, ISBN non esistente.
- Emilio Bodrero, Il principio fondamentale del sistema di Empedocle. Studio preceduto da un saggio bibliografico e dalla traduzione dei frammenti empedoclei, Roma, G. Bretschneider, 1975, ISBN non esistente.
- Livio Rossetti e Carlo Santaniello, Studi sul pensiero e sulla lingua di Empedocle, Bari, Levante, 2004, ISBN 88-7949-355-8.
- Jacquemard Simonne, Tre mistici greci. Orfeo, Pitagora, Empedocle, traduzione di M. Marino, Isola del Liri (FR), Pisani editore, 2004, ISBN 88-87122-42-3.
- Peter Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, Milano, Il Saggiatore, 2007, ISBN 978-88-428-1033-9.
- Federica Montevecchi, Empedocle d'Agrigento, Napoli, Liguori, 2010 (il volume è corredato da una nuova traduzione con testo greco a fronte di tutti i frammenti, compresi quelli del papiro di Strasburgo), ISBN 978-88-207-5043-5.
- Federica Montevecchi, Sull'Empedocle di Giorgio Colli, Luca Sossella Editore, Milano, 2018 (ISBN 978-88-97356-69-1)
- Fernanda Decleva Caizzi, Reviewed Work: L'Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv. 1665-1666) by Alain Martin, Olivier Primavesi, in Rivista di Storia della Filosofia (1984-), Vol. 55, No. 4 (2000), pp. 691-694, JSTOR 44024580, OCLC 7788166308.
Note
- Secondo le discordanti fonti sulla vita di Empedocle «… la cronologia di Empedocle andrebbe fissata tra il 484-1 e il 424-1» (Cfr. Gabriele Giannantoni, I presocratici. Testimonianze e frammenti, Roma-Bari 1986. Vol. I, pp.323-4). Secondo E. Bignone (in Empedocle: studio critico, traduzione e commentario delle testimonianze e dei frammenti, Torino 1916) Empedocle sarebbe vissuto tra il 492 a.C. e il 432 a.C. Anche L. Robin ritiene che «La sua vita… sembra sia scorsa tra il primo decennio del secolo V e il 430 circa» (in Storia del pensiero greco, Torino 1978, p. 131). In uno studio recente M. J. Schiefsky ritiene che Empedocle sia nato nel 490 a.C. e morto nel 430 a.C. (in Hippocrates, On ancient Medicine, Leida-Boston 2005, p. 63).
- Mattia Cavadini, La morte di Empedocle, su rsi.ch, RSI. URL consultato il 7 settembre 2021.
- Denis O'Brien, Empedocle in Il sapere greco. Dizionario critico, vol. 2, a cura di Jacques Brunschwig ed E.R. Lloyd, Torino, Einaudi, 2007, p. 82.
- Platone, Parmenide, 127 B.
- Platone, Parmenide, 127 C.
- Diogene Laerzio, VIII, 51.
- Diogene Laerzio, VIII. 73.
- Timeo, ap. Diogene Laerzio, VIII. 64, comp. 65, 66.
- Aristotele ap. Diogene Laerzio, VIII. 63; cfr. Timeo, ap. Diogene Laerzio, 66, 76.
- Diogene Laerzio, VIII, 66, 67.
- Erica Joy Mannucci, La cena di Pitagora, Carocci editore, 2008, p. 19.
- Satiro, ap. Diogene Laerzio, VIII. 78; Timeo, ap. Diogene Laerzio, 67.
- Una poderosa rappresentazione pittorica di questo evento storico si trova sul telone del Teatro Selinus di Castelvetrano, dipinto nel 1906 dal pittore Gennaro Pardo; cfr. Il sipario del Teatro Selinus dipinto da Gennaro Pardo, su sipario.it. URL consultato il 7 settembre 2021.
- Diogene Laerzio, VIII. 60, 70, 69.
- Plutarco, de Curios. Princ., Adv. Colote, Plinio, HN XXXVI. 27, e altri.
- Così nella letteratura antica, come riferisce Bertrand Russel nella sua Storia della filosofia occidentale, citando un poeta anonimo: «Grande Empedocle che, l'anima ardente, saltò in Etna, ed è stato arrostito intero».
- Diogene Laerzio, VIII. 67, 69, 70, 71; Orazio, ad Pison. 464, ecc.
-
Cfr. anche Eraclide Pontico, fr. 83 Wehrli, citato in Luciano De Crescenzo, Storia della filosofia greca. I Presocratici, Mondadori.«Ippoboto riferisce che egli, levatosi, si diresse all'Etna e, giunto ai crateri di fuoco, vi si lanciò e scomparve, volendo confermare la fama che correva intorno a lui, che era diventato dio. Successivamente fu riconosciuta la verità, poiché uno dei suoi calzari fu rilanciato in alto; infatti, egli era solito usare calzari di bronzo.» (Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, VIII, 68-69) -
«E questo tutto abbrustolito chi è? - Empedocle. - Si può sapere perché ti gettasti nel cratere dell'Etna? - Per un eccesso di malinconia. - No: per orgoglio, per sparire dal mondo e farti credere un dio. Ma il fuoco rigettò una scarpa e il trucco fu scoperto» (Luciano di Samosata, I dialoghi; BUR, Rizzoli, 1990) - «Timeo ci attesta esser lui finito di morte naturale nel Peloponneso. Dicono alcuni che trovandosi egli in Messina a cagion di una festa sia ivi caduto da un carro, e rottasi la coscia, sia morto. Credono altri che in mare naufragasse: altri che si fosse strangolato da sé.» (In Domenico Scinà, Memorie sulla vita e filosofia d'Empedocle gergentino, ed. Lo Bianco, Palermo 1859, p. 55.
- Apollonio, ap. Diogene Laerzio, VIII. 52, comp. 74, 73.
- Suda, e 1004 (II, p. 259 Adler).
- Wolfgang Haase, 2, Principat ; 36, Philosophie, Wissenschaften, Technik 6, Philosophie (Doxographica [Forts.]), Volume 36, ed. Walter de Gruyter, 1992 p. 4207 nota 111.
- Franco Volpi, Dizionario delle opere filosofiche, Bruno Mondadori 2000, p.327)
- A proporre tale ipotesi fu Catherine Osborne in Empedocles Recycled, The Classical Quarterly 37 (01):24-50 (1987).
- Alberto Jori, Empedocle in Dizionario delle opere filosofiche, Milano, Bruno Mondadori, 2000, p. 327.
- Avverte infatti il Jaeger: «Dobbiamo guardarci dal prendere per pura metafora poetica l'espressione della religiosità che lo trattiene dal seguire sino in fondo i predecessori troppo sicuri di sé.» (Werner Jaeger, La teologia ... p. 211).
- Aldo Cardin, Empedocle, in Enciclopedia filosofica, vol. 4, Milano, Bompiani, p. 3338.
- Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 1, p. 213.
- D-K 31 B 7.
- D-K 31 B 17.
- Peter Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, Milano, Il Saggiatore, 2007, ISBN 978-88-428-1033-9.
- In corrispondenza con le quattro primarie antitesi del caldo, del freddo, dell'asciutto e dell'umido (cfr. Werner Jaeger, La teologia ..., p. 214)
- Le quattro "radici" di Empedocle risultano essere poi i quattro "elementi" di Aristotele e Tolomeo.
- Edoneo o Aidoneo (Ἀϊδωνεύς) è un appellativo proprio del dio degli inferi Ade, cfr. in tal senso Esiodo Teogonia, 913; o anche inno omerico A Demetra.
- Forse si riferisce a Persefone; per una dotta riflessione su questo nome, certamente un teonimo poco conosciuto, si rimanda alla nota 55, p. 173 di Carlo Gallavotti in Empedocle, Poema fisico e lustrale, Milano, Mondadori/Lorenzo Valla, 2013.
- Werner Jaeger, La teologia ..., p. 214.
- D-K 31 B 17, B 22, B 66, B 71
- D-K 31 B73, B 75, B 95, B 98.
- Werner Jaeger, La teologia... p. 215.
- Werner Jaeger, La teologia... p. 236.
- D-K 31 B 19
- D-K 31 B 28.
- Denis O'Brien, Empedocle, pp. 85-86.
- Secondo Empedocle (B 62; 63) i sessi furono determinati dalla separazione di creature "di natura integra", che si erano a loro volta evolute da forma di vita più primitive. Secondo la Brhadāraṇyaka Upanishad (1, 4, 1-3), l'universo iniziò come Io in forma umana. Questo Io era solo e annoiato:
«Ora egli aveva la grandezza di un uomo e di una donna abbracciati strettamente. Egli divise questo Io in due parti, e da questo sorsero marito e moglie» (Martin Litchfield West, La filosofia greca arcaica e l'Oriente, pag. 307, Il Mulino, Bologna, 1993) - Un papiro di recente ritrovamento, contenente nuovi scritti di Empedocle, ha consentito tuttavia di integrare le due versioni, portando a ritenerle complementari. Le due opere, quindi, farebbero forse parte di uno stesso trattato, cfr. Empedocle di Agrigento, su intermed.it. URL consultato il 18 febbraio 2013 (archiviato il 5 agosto 2010).
- «In tempi più recenti, è stata avanzata l'ipotesi che si tratti di Empedocle di Agrigento (492-432 a.C.). Tale proposta trova conforto sia nella notizia di Diogene Laerzio in merito alla folta chioma del personaggio sia alla specifica collocazione del bronzo all'interno della villa dove faceva pendant con il bronzo raffigurante Pitagora (inv. 5607), che fu suo maestro» ( Museo archeologico Nazionale di Napoli (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2016).).
- Ernest Renan, Vingt jours en Sicilie. Mélanges d'histoire et de voyages, p. 103, citato in Luciano De Crescenzo, op. cit.
- Alain Martin e Fernanda Decleva Caizzi, Review: [Untitled] Reviewed Work: L'Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv. 1665-1666) by Alain Martin, Olivier Primavesi, in Rivista di Storia della Filosofia (1984), vol. 55, n. 4, 2000, pp. 691-694, ISSN 0393-2516, JSTOR 44024580, OCLC 7788166308.
- Franco Volpi, Empedocle: i suoi misteri rivelati in una biblioteca, 13 novembre 1998. URL consultato il 7 settembre 2021.
- Empedocle di Agrigento (PDF), Università di Milano, p. 1.
- Il papiro era stato acquistato infatti nel 1905 insieme ad altri 52 pezzi di varie dimensioni[49], che sono i frammenti in cui il rotolo si frantumò prima di finire a Berlino ed essere assegnato alla Biblioteca di Strasburgo a seguito di un tiro a sorte[50]. Nel 1994, lo stesso Martin ne attribuì l'appartenenza ai primi due libri della Physika[51].
- Filosofi: Empedocle, scoperto papiro a Strasburgo. Per gli studiosi è l'unica testimonianza diretta, Strasburgo, Adnkronos, 28 gennaio 1999. URL consultato il 30 novembre 2020.
Voci correlate
- Presocratici
- Religione dell'antica Grecia
- Quattro elementi
Altri progetti
 Wikibooks contiene un approfondimento su Amore e Odio: genesi del mondo in Empedocle
Wikibooks contiene un approfondimento su Amore e Odio: genesi del mondo in Empedocle
 Wikisource contiene una pagina dedicata a Empedocle
Wikisource contiene una pagina dedicata a Empedocle Wikisource contiene una pagina in lingua greca dedicata a Empedocle
Wikisource contiene una pagina in lingua greca dedicata a Empedocle Wikiquote contiene citazioni di o su Empedocle
Wikiquote contiene citazioni di o su Empedocle Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Empedocle
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Empedocle
Collegamenti esterni
- Empèdocle, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- Guido Calogero, EMPEDOCLE d'Agrigento, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1932.
- Empedocle, in Dizionario di filosofia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.
- Empèdocle, su sapere.it, De Agostini.
- (EN) Empedocle, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Empedocle, su MacTutor, University of St Andrews, Scotland.
- Opere di Empedocle, su openMLOL, Horizons Unlimited srl.
- (EN) Opere di Empedocle, su Open Library, Internet Archive.
- (EN) Audiolibri di Empedocle, su LibriVox.
- (EN) K. Scarlett Kingsley, Richard Parry, Empedocles, in Edward N. Zalta (a cura di), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Università di Stanford.
- (EN) Gordon Campbell, Empedocles (c. 492—432 B.C.E.), su Internet Encyclopedia of Philosophy.
- (FR) Jean-Claude Picot, Empedocles, su sites.google.com. (con ampia bibliografia).
- Empedocle, su liberliber.it, Liber Liber. URL consultato il 7 settembre 2021.
- Empèdocle, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 7 settembre 2021.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 297576907 · ISNI (EN) 0000 0003 8281 6072 · BAV 495/42018 · CERL cnp00930916 · Europeana agent/base/195 · ULAN (EN) 500212584 · LCCN (EN) n79134944 · GND (DE) 118530224 · BNE (ES) XX1154313 (data) · BNF (FR) cb11929776m (data) · J9U (EN, HE) 987007260864205171 · NSK (HR) 000079904 · NDL (EN, JA) 00620630 · CONOR.SI (SL) 50996067 · WorldCat Identities (EN) lccn-n79134944 |
|---|
На других языках
[en] Empedocles
Empedocles (/ɛmˈpɛdəkliːz/; Greek: Ἐμπεδοκλῆς; c. 494 – c. 434 BC, fl. 444–443 BC) was a Greek pre-Socratic philosopher and a native citizen of Akragas, a Greek city in Sicily. Empedocles' philosophy is best known for originating the cosmogonic theory of the four classical elements. He also proposed forces he called Love and Strife which would mix and separate the elements, respectively.[fr] Empédocle
Empédocle (en grec ancien : Ἐμπεδοκλῆς / Empedoklês) est un philosophe, poète, ingénieur et médecin grec de Sicile, du Ve siècle av. J.-C. Il fait partie des philosophes présocratiques, ces premiers penseurs qui ont tenté de découvrir l'arkhè du cosmos, son « schéma ». L'originalité d'Empédocle est de poser deux principes qui règnent cycliquement sur l'univers, l'Amour et la Haine. Ces principes engendrent les quatre éléments dont sont composées toutes les choses matérielles : l'eau, la terre, le feu et l'éther (ou l'air). L'Amour est une force d'unification et de cohésion qui fait tendre les choses vers l'unité (par exemple les organismes vivants) ou même l'Un quand il s'agit du cosmos. La Haine est une force de division et de destruction qui fait tendre les choses vers le multiple.- [it] Empedocle
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии